Nello scorso articolo mi sono occupato di Woodstock in relazione alla performance di Jimi Hendrix, che in qualche modo chiude quell’evento mirabilante e irripetibile. Grazie a Paola Siragna, violoncellista, musicologa e autrice dell’interessantissimo saggio Woodstock e poi… (Mimesis, 2019), possiamo ora allargare lo sguardo agli anni che hanno portato al Festival più famoso della storia e ai semi che ha sparso nella cultura e nella società occidentale.
Quali sono stati i fermenti e gli ingredienti fondamentali che hanno reso possibile un evento del genere e quali, delle utopie che ha incarnato, resistono secondo te al passare dei decenni?
C’era un bisogno da parte dei giovani di far sentire la propria voce che non è paragonabile ad oggi. Un desiderio di libertà, di espressione di sé, di autodeterminazione, di essere presenti “nel momento”. Già la mia generazione non ha vissuto un fermento analogo, non abbiamo dovuto combattere grandi battaglie. Siamo in qualche modo cresciuti sul tappeto rosso steso dai nostri genitori. Oggi i ragazzi si illudono di riuscire a comunicare attraverso i social media, ma è una comunicazione mediata e fasulla. È una corsa ad apparire, ma individualmente. È come se non si sentisse una reale necessità di essere ascoltati in quanto gruppo. Ciononostante il fatto che anche molti giovani oggi si avvicinino alla filosofia hippie, unitamente ai nuovi movimenti che sostengono l’ambiente, la vita a contatto con la natura, il rispetto della Terra in quanto nostra casa, le pratiche legate alla meditazione, sono segni tangibili di ciò che gli hippie hanno seminato negli anni Sessanta.
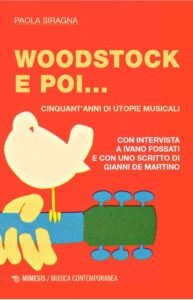
Nel libro ti occupi del “sogno hippie” e anche delle sue zone d’ombra: qual è stata la sua evoluzione da allora a oggi nella cultura di massa?
Il “sogno hippie” sopravvive, ne sono convinta. Forse negli anni Novanta c’è stata una leggera inflessione, fra il sopravvento delle discoteche come luogo di aggregazione e l’avanzata delle droghe sintetiche. Gli hippie hanno lasciato il posto ai “ragazzi dello zoo di Berlino”, ma paradossalmente negli ultimi decenni c’è stato un forte ritorno agli anni Sessanta. Nel libro mi sono divertita a trovare influenze hippie persino nei cartoni animati. Le zone d’ombra permangono, magari in modo meno eclatante, più nascosto, più diluito. In particolare la commercializzazione di questo stile di vita, che diventa moda e riempie le tasche delle multinazionali. Basti pensare a quanto l’industria del fast fashion abbia attinto dalla moda di quegli anni. Ma credo sia inevitabile.
Quanto a ideali come pacifismo e non-violenza, che lo stesso Hendrix ha messo in arte a modo suo, senza ideologismi alle spalle, cosa ha significato Woodstock e in che modo può ancora essere preso a riferimento oggi?
Woodstock ha insegnato al mondo come ideali pacifisti e amore per la musica possano essere un potentissimo mezzo di aggregazione, in grado di lanciare messaggi forti. Le idee, se sostenute in gruppo, possono essere l’arma più potente ed efficace in assoluto, in grado di mettere in discussione un intero sistema. Oggi abbiamo mezzi di comunicazione veloci ed efficienti, ma meno efficaci. Dovremmo imparare ad utilizzare davvero gli strumenti che abbiamo. E soprattutto dovremmo imparare ad “esserci” di più e “mostrarci” di meno.
Una parte particolarmente interessante del tuo libro è l’eco che Woodstock ha avuto in Italia…
In questo viaggio nel sogno hippie italiano è stata determinante la testimonianza di Ivano Fossati. Lui ha confermato quanto quegli anni fossero pieni di fermento e come si guardasse alla musica d’oltreoceano con stupore e gratitudine. C’era voglia di guardare al di là dei propri confini, voglia di scoprire, di sperimentare, di emulare in qualche modo, pur senza perdere la propria identità. Il successo di Jesahel a Sanremo ne è emblema. Bisogna riconoscere che la musica italiana degli anni Settanta debba molto agli artisti americani coevi.
Hai dedicato due libri anche alla “filosofia” di alcuni musicisti iconici per epoche diverse, come Queen e Nirvana. In che modo sei riuscita a cogliere un “nucleo filosofico” in queste due band così differenti?
Credo che la produzione artistica di grande spessore abbia sempre un fondamento filosofico, magari nascosto o inconsapevole. Con i Nirvana è stato piuttosto semplice riconoscere all’interno dei testi una sorta di nichilismo, di pessimismo cosmico, di ricerca di introspezione talmente evidente da essere quasi paragonabile a quella di un bambino che richiede attenzioni. C’è molto di più di quello che appaia ad un primo ascolto. Ho passato mesi ascoltando e riascoltando i loro brani e credo di aver riscontrato in Cobain una sincerità ed una rassegnazione disarmanti. E in qualche modo persino contagiose.
Con i Queen è stato diverso. Con loro non posso dire di essere imparziale, hanno fatto parte della mia vita da sempre. Li ho solo ascoltati con maggiore consapevolezza. Freddie era un esteta con una buona dose di follia. Il richiamo al contrasto fra l’apollineo e il dionisiaco di cui parla Nietzsche è stato immediato.
Nel caso della band di Kurt Cobain, alla quale sono stato intensamente legato in un periodo irripetibile come gli anni liceali, confesso che avrei fatto molta fatica a studiare e ri-avvicinare ora la loro poetica. Tu che approccio hai scelto e quali chiavi hai usato per entrare “Dentro i Nirvana”?
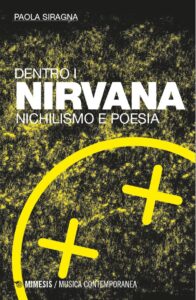
Per me forse è stato più facile proprio perché non li ho scoperti in età liceale, ma subito dopo, una volta passati i vent’anni. Mi hanno accompagnato nel periodo universitario e sentivo che avevano ancora molte cose da dirmi, al di là dell’aspetto “ribelle” della loro musica. Inoltre con gli anni ho conosciuto anche altri gruppi grunge e volevo individuare differenze e punti di contatto, andare più a fondo nell’aspetto testuale. Ho scoperto nei testi di Cobain riferimenti letterari straordinari. Ho lavorato principalmente su questo e sulla costruzione musicale dei brani, semplice ma incredibilmente efficace. Cobain quello che vuole dire te lo mette proprio davanti agli occhi. Bisogna solo saperlo cogliere.

